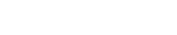Un capitolo in anteprima da ‘Mi vivi dentro’ di Alessandro Milan: non è una favola, quella di Alessandro e di Wondy. È però una storia piena di speranza, di amore, di attaccamento alla vita; un inno alla resilienza, quella da esercitare quotidianamente. Perché le storie più belle non hanno il lieto fine: semplicemente non finiscono.
1
La clessidra
—Cammino sul lungomare di Sámara, in Costa Rica. Avanzo zigzagando, con la testa bassa, lo sguardo fisso sui piedi che a ogni passo affondano nella sabbia. Le dita spariscono per un attimo, immerse tra i granelli dorati che contrastano col bianco della pelle. Ne avverto anche il suono, una sorta di croc. Di tanto in tanto alzo gli occhi in cerca di una zona soleggiata. Mi dirigo lì, e mentre continuo ad avanzare mi colpisce lo sbalzo di temperatura. Quando il bruciore ai piedi diventa insopportabile, torno al riparo di una palma e l’approdo mi dà sollievo e qualche brivido lungo la schiena.
Dev’essere l’ora dell’alta marea, perché la riva si sta ritirando. Vedo due persone a cavallo, in lontananza. Tra me e loro, il vuoto. Abbasso gli occhi. Poi mi lascio cadere, l’atterraggio è soffice, un pof sulle tibie e sulle rotule. Osservo per un attimo al largo, il cielo è talmente terso e il mare talmente blu che fatico a distinguere la linea dell’orizzonte. Sorrido e rimango incantato qualche secondo davanti a quel paesaggio. Nel frattempo le persone a cavallo si sono avvicinate, ora passano dietro di me, a pochi metri. Sono due bambini, che si dicono qualcosa e ridono, ma le loro parole mi arrivano ovattate. Gli zoccoli dei cavalli, invece, non fanno rumore.
Improvvisamente guardo giù e affondo le mani nella sabbia. Eppure non ne percepisco il calore. Quando sono tutte e due coperte, le stringo a pugno, poi le sollevo, ma le dita sembrano di vetro, non trattengono neppure un granello. Riprovo. Immergo entrambi i palmi nell’oro, chiudo, li sollevo. Sono vuoti. Provo una terza volta. Non racimolo nulla. Lieve la sabbia scivola via, scorre come quella di una clessidra. Solo che questa non si può capovolgere, cade per sempre.
Il rumore di una porta che si chiude alle mie spalle mi fa riaprire gli occhi e mi riporta alla realtà. Devo essermi addormentato per qualche istante.
Sono in ospedale, seduto in uno di quegli slarghi tra un reparto e l’altro che sembrano fatti apposta per spingerti a meditare sulla mestizia dei muri e degli arredi. Perché sono sempre così tristi, illuminati da luci fredde che ti fanno perdere la cognizione del tempo? Rischi di non distinguere il giorno dalla notte, se non hai un orologio o una finestra nei paraggi.
La mamma di Francesca mi raggiunge. Si siede al mio fianco. I suoi capelli corti, sempre precisi e pettinati, mi paiono di colpo arruffati, la sua consueta grinta si è spenta. Da alcuni giorni pende dalle mie labbra, oltre che da quelle dei dottori. Ma io non ho certezze da offrirle, anzi.
Sospira, gli occhi le si velano di lacrime.
«Mi siedo qui, accanto al mio “generino”».
Io non rispondo, guardo fisso davanti a me.
«Ma sta succedendo davvero?» aggiunge. Non so quante volte me lo ha già chiesto.
Io non ho molto da dire. «Eh… Pare…» bofonchio.
Restiamo in silenzio due o tre minuti, durante i quali penso che per lei dev’essere ancora più difficile che per me. Lei, in fin dei conti, è la mamma.
Giocherello con le dita della mano destra sul bracciolo della poltrona, la schiena e il sedere affondati nel cuscino, le gambe protese in avanti. Lei invece è composta, ritta, come a volersi tenere su. Ha un fazzoletto di carta tra le mani, e lo tormenta in continuazione. Ormai è diventato macilento.
Poi lei si alza. «Ho bisogno di fare due passi» dice. E si allontana.
È allora che accade. Un incontro casuale, perché la dottoressa che mi passa davanti era diretta in tutt’altra direzione, non stava venendo da me. La conosco, o meglio l’ho intravista nei giorni scorsi: Francesca è ricoverata nel reparto del primario dal quale lei dipende. Sapete quelle scene da film in cui il luminare fa il giro delle stanze per controllare lo stato dei pazienti e attorno a sé ha tutto quel codazzo di vice, aiutanti e specializzandi che lo seguono come se fosse il pifferaio magico? Ecco, l’ho notata due o tre volte in quelle occasioni. È giovane, non ha lo sguardo sperduto dei colleghi di primo pelo ma nemmeno la corazza o il tono ieratico del professorone. In più è donna, e probabilmente mi convinco che questo possa averla dotata di una sensibilità e un’empatia maggiore nei confronti di mia moglie.
Non so neppure se mi abbia riconosciuto, ma quando i nostri occhi si incrociano è come se mettesse a fuoco la situazione. Magari avrebbe preferito tirare dritto per la sua strada, ma viene verso di me. Il suo avvicinarsi mi fa scattare qualcosa nella testa, non so esattamente cosa. Forse è che conosco troppo gli altri medici e allora sospetto che mi parlino con una sorta di freno a mano tirato, che non riescano a essere del tutto sinceri perché vogliono troppo bene a Francesca, e anche a me. Sta di fatto che scelgo lei.
«Scusi, dottoressa, non so a chi altro chiedere…».
«A che proposito, mi dica».
«Senta, mia moglie… È così compromessa la situazione?».
Lei dapprima abbassa un pochino lo sguardo, poi mi fissa negli occhi e accenna un sì con la testa.
«Ok. Ma… “compromessa” cosa vuol dire?».
Certo, l’ho chiesto io. Lo so bene. Ma uno può scegliere le domande, non le risposte.
«Mi spiace doverglielo dire io, perché vi conosco poco. Ma tra un mese, al massimo tre, sua moglie non ci sarà più».
No.
Non è vero.
Non può averlo detto.
Non può.
D’accordo, Franci sta male, la situazione è complicata, di più, magari anche disperata, ma non può averlo detto.
Oggi è il 9 novembre, tra un mese e mezzo è Natale. L’albero, le luci colorate, i regali, chissà magari uno spruzzo di neve.
Un mese, al massimo tre?
Forse vedremo l’anno nuovo insieme, forse no.
Sento il pianto sgorgare da dentro, trovando uno sfogo prima nello stomaco, poi nella gola, infine nella bocca, nel naso. Come un’esplosione dall’interno verso l’esterno. Incontrollabile.
Farfuglio qualcosa, inizio a voltarmi da ogni parte in maniera compulsiva, evitando il suo sguardo, per vergogna e pudore. Forse mi esce un «va bene» strozzato nelle corde vocali, o forse non dico niente. Poi mi alzo e imbocco il corridoio. Mentre mi allontano sento che la dottoressa mi chiama, ma non posso restare qui. Non voglio sentire altro.
Raccolgo le forze per recuperare lucidità, perché sto per passare vicino alla stanza di Franci e potrei incontrare qualcuno tra infermieri, parenti e dottori.
Un’occhiata veloce e invece niente, per fortuna. Via libera, non c’è nessuno. Anzi no, c’è Stefano, il dermatologo, anche lui estraneo in questo reparto, è venuto qui solo per noi. Tenta di salutarmi ma gli faccio un cenno come a dire “no, non ora” e a grandi falcate attraverso il corridoio. Devo trovare un posto dove piangere, da solo. Sento che devo buttare fuori tutto.
Vado dalla parte opposta, dove c’è un altro salone, solite pareti grigie e neon. Mi siedo lì e lascio che gli argini vengano travolti dalla piena. Mi prendo il volto tra le mani, le spalle iniziano a sussultare per i singhiozzi. Il Natale… C’è l’albero da fare tutti insieme. Cazzo, Franci è forte, com’è possibile? Noi dobbiamo fare ancora tante cose. Mi strofino la fronte, le guance, mi ingobbisco, mi rannicchio e fisso il pavimento. Piango e sento che ho la bocca aperta, mi sembra spalancata, ora trema. Me la copro, per vergogna. Ma da chi ti nascondi, Ale? ’Fanculo, in ospedale si piange, no? No, no, non è possibile, ora vado di là e dico alla dottoressa che si è sbagliata.
Un mese, al massimo tre. D’improvviso la sabbia della clessidra ha preso a cadere più in fretta.
È poco tempo. Maledettamente poco. E ora che faccio? Cosa dico a sua mamma, a suo papà? Chi mi aiuterà? A un certo punto mi sembra quasi di avvertire un conato di vomito.
Non dire nulla, Ale. Nulla. Niente di niente, questa conversazione non è mai avvenuta.
Tiro su con il naso, provo a calmarmi, poi mi massaggio le tempie con le dita, mi strofino le sopracciglia. Lo sbuffo d’aria che butto fuori è il segnale che il peggio è passato.
Ora sono impaziente. Sento che non posso più restare qui, seduto. Sono già venti minuti che manco dalla stanza di Francesca ed è bene farsi vedere, prima che si insospettisca. E poi, se il tempo che ci resta è un mese o al massimo tre, questi minuti sono già stati uno spreco enorme. Ora ogni granello di quella sabbia vale dieci volte di più.
Così imbocco di nuovo il corridoio. Mi asciugo le lacrime da sotto gli occhi, che immagino siano rossi, gonfi, inguardabili. Sono sconvolto, la vista è appannata. Riesco a scorgere a una decina di metri da me la chiazza bianca di un camice. È ancora Stefano. Mi rendo conto che poco fa sono stato scortese, scacciandolo con la mano, perciò gli vado incontro e lo saluto. Lui mi fissa e non sa cosa dire, non apre bocca, visibilmente imbarazzato. Anche perché – me ne rendo conto soltanto adesso, girando appena la testa – di fronte a lui c’è…
Oddio, è Franci. Ce l’ho a un metro e mezzo e non me n’ero accorto.
La guardo.
Mi guarda.
È il panico, in un attimo.
So di avere il volto devastato. Allora improvviso uno di quei sorrisi ebeti, automatici, come a dire: “Ehi, eccomi, come stai?”.
L’istantanea successiva mi accompagnerà per il resto della vita.
Franci mi sorride. Senza dire nulla.
“Ho capito, Ale”. Ecco cosa mi sta dicendo. “Lo so, Ale”.
Ma è un sorriso dolce, senza la minima traccia di rabbia, senza tristezza, malinconia. Solo tanto dispiacere, come se volesse dirmi: “Non ti preoccupare, andrà tutto bene”.
Ora io so. Ora lei sa. Ora sappiamo. Ma esplicitamente non ce lo diremo mai.
* * *Aprile 2001
La macchinetta del caffè in fondo al corridoio offriva una miscela abbastanza imbevibile ma erano le sei di mattina, dovevo iniziare il turno nella redazione news e quindi c’era poco da scialare: bisognava accontentarsi di quel che passava il convento. La biondina con i capelli sempre sparati invece aveva fatto la notte e se ne stava andando. Era più stropicciata del solito, gli occhiali da sole cercavano di nascondere i segni della stanchezza.
Da qualche tempo avevo notato che mi ronzava intorno, il che non mi dispiaceva affatto. Era piccolina, per non dire bassina, ma caruccia forte; occhi giganti di un blu mai visto, sempre sorridente, costantemente spettinata. Gran bel tipo. Spesso mi chiedeva una mano per i voice-over, le traduzioni in italiano che vanno in onda sopra alle voci originali: «Alessandro, scusa, tu che sai bene l’inglese, mi aiuti con questa dichiarazione di Bush?». Un po’ utilitaristico, come ronzamento intorno, ma mi accontentavo.
Stavolta invece niente, aveva tirato dritto. Così, mandato giù il caffè avevo raggiunto la postazione e mi ero messo a lavorare. Il caporedattore mi aveva assegnato confezionamento e lettura in diretta del giornale radio sport. Era quello che speravo. Non comportava un grande sbattimento. Bisognava sistemare le notizie preparate da un collega la sera prima, controllare che le agenzie e i quotidiani del mattino non riportassero qualche novità imprescindibile da aggiungere, e poi andare in onda dopo il giornale radio. Un qualcosa che ti teneva al riparo da ulteriori incarichi fino alle nove. Evitavo così il rischio di occuparmi di faccende poco esaltanti come “il gelo record che stava attanagliando il Centro-Sud”. Insomma, mi ero risparmiato grandi rotture di palle per l’inizio della giornata.
Dopo un paio d’ore però avevo notato che mancava qualcosa: il cellulare. Oh cribbio, dove l’ho messo? Eppure quando sono uscito da casa ce l’avevo…
Avevo cominciato a cercarlo ovunque, in borsa, nella giacca, e sul tavolo avevo spostato giornali, libri, fogli di carta. Alla fine per fortuna era saltato fuori. Peccato però che non fosse il mio. Sì, il modello era esattamente lo stesso, e pure il colore, ma quello che avevo in mano era il Nokia della biondina. E se quello era il suo… Oh cazzo, stai a vedere che si è presa il mio!
Non restava che chiamarla, cioè non restava che chiamare il mio numero e vedere se rispondeva lei. Solo che figurati, dopo il turno di notte era sicuramente andata a dormire.
E infatti due squilli, tre, quattro. Niente, nessuna risposta.
Avevo aspettato dieci minuti prima di riprovare. Due squilli, tre, quattro.
Al terzo tentativo una voce dall’oltretomba aveva biascicato: «P… pronto?».
Io, con un atteggiamento misto di sorpresa e rimprovero: «Ma… Del Rosso!».
«Sì, chi è?».
«Francesca, sono Alessandro Milan, quello è il mio cellulare».
Lei, rincoglionita dalla sveglia inaspettata: «Eh sì, questo è il mio cellulare… e allora?».
«No, non hai capito… Ti chiamo dalla redazione, quando sei andata via ti sei presa il mio Nokia, e hai lasciato qua il tuo. Ora stai rispondendo dal mio».
Pausa chilometrica.
«Oh porca puttana, scusa scusa, sono rimbambita». Risatina. «E adesso?».
«Senti, non ti preoccupare, spegnilo pure, io faccio lo stesso con il tuo e poi quando finisco il turno vengo a recuperarlo, ok?».
«Va bene, scusami ancora. Dài, ti aspetto».
«Eh, però mi dovresti dare il tuo indirizzo».
«Sì certo, via Vallazze 87».
All’una e mezza ero a casa Del Rosso. Forte della convinzione di piacerle, durante il tragitto mi ero fatto tutto un film: che ne so, magari da quel piccolo malinteso sarebbe venuto fuori qualcosa, un caffè, due chiacchiere, un pomeriggio insieme. Visto il gelo, magari la invito a bere una cioccolata. Dalle sue parti c’era Città Studi, il quartiere dell’università, era pieno di baretti carini. Oppure, ecco, l’avrei potuta portare a mangiare un kebab, una roba giovanile, informale, da studentelli fuori corso. Se poi era una di quelle precisine e attente alla salute, ero persino disposto a sorbirmi un concentrato di carote, una di quelle minchiate finto salutiste. In fondo io avevo appena finito il mio turno e lei non avrebbe attaccato il suo fino a mezzanotte; c’era tempo, no? Ma poi mi ero detto: Di lei non so quasi niente. Col culo che ho, magari arrivo là e mi apre la mamma, o peggio il papà, o peggio ancora il suo ragazzo. Dài, meglio non illudersi.
Avevo parcheggiato, suonato al citofono: «Sono Milan, per il cellulare».
«Sì, vieni. Primo piano».
Lei mi aveva sentito salire per le scale ed era venuta alla porta in vestaglia, ancora più arruffata di come l’avevo vista qualche ora prima.
«Scusa, mi sono svegliata da poco, ecco il telefono».
«Certo, tieni il tuo».
«E allora ciao. E scusami ancora per il casino».
«Niente, niente».
Poi la porta si era richiusa ed ero rimasto lì impalato come un pirla. Non ero riuscito neanche a mettere un piede sullo zerbino. Mica male. Già, ma che cazzo ti aspettavi, Ale, su. Cosa pretendevi? Di arrivare qui, bello bello, e che da un equivoco nascesse una storia d’amore? Non sei esattamente George Clooney… Anche se lei, a dirla tutta, qualcosa di Meg Ryan ce l’aveva: gli occhioni, la bocca, il sorriso.
Stavo per andare via, quando avevo sentito la porta di casa riaprirsi.
Evvai, stai a vedere che invece ci siamo.
«Ale, scusa, non scappare via subito».
Sì sì sì. Ci siamo. È fatta!
«Dimmi pure, Del Rosso».
Facevo il tranquillo ma mentalmente mi vedevo già senza camicia sul suo divano.
«Non so come dirtelo…».
E via le scarpe.
«Non trattenerti» le avevo detto.
E via anche i pantaloni.
«Ecco, è che… il caporedattore mi ha appioppato una traduzione pallosissima di un’intervista a Woody Allen che non so come fare. Non è che domani arriveresti mezz’ora prima al lavoro per darmi una mano?».
Cosa? Woody Allen?! Se c’è uno che mi sta sulle palle, è proprio lui.
«Ma certo, per un genio del cinema questo e altro. Facciamo un’ora prima, che così siamo tutti più tranquilli?».
«Sei un mito, grazie. A domani».
E la porta si era richiusa senza se e senza ma.
Il borsone del calcetto era pronto, dovevo andare a Monza e raggiungere gli amici per la classica partitella tra sfigati. Era domenica, una di quelle giornate in cui mamma a pranzo viziava me, i miei tre fratelli e papà con manicaretti di ogni tipo, accompagnati da una vagonata di patatine fritte. Roba da cappottarsi poi sul divano e abbandonarsi a una pennica di un paio d’ore, interrotta magari solo dalla partita del Milan in TV. Altro che sgambettare dietro a un pallone.
Il telefono era squillato.
«Pronto?».
«Ciao Alessandro, sono Francesca. Del Rosso».
«Ah, ciao».
Sempre stato un gran seduttore, io.
«Senti, ti va di andare al cinema?».
Come come? Stavolta niente traduzioni? Dove stava la fregatura?
«Quindi?» aveva insistito, dato che io non rispondevo. «Sempre se puoi eh».
In un lampo mi ero immaginato il coro di insulti degli amici che mi avrebbe investito se le avessi detto sì. D’altronde chi gioca a calcetto lo sa: non c’è cosa peggiore di un pacco tirato da uno dei dieci all’ultimo minuto. In nove, che razza di partita può venir fuori?
«Certo che posso! Non avevo niente da fare oggi pomeriggio».
«Bello. Allora ci vediamo alle cinque al Plinius. Andiamo a vedere Le fate ignoranti. Ciao».
E aveva attaccato.
Altra prerogativa della Del Rosso: aveva già deciso tutto prima, orario, cinema e film, senza possibilità di discutere.
Però stavolta aveva anche deciso che voleva me. No dico, proprio me, Alessandro.
Al volo avevo fatto mentalmente l’appello e scelto l’amico che pensavo si sarebbe arrabbiato di meno, Sergio. Mi ero beccato comunque la mia prevedibile razione di vaffa… Ma vuoi mettere? Andavo al cinema con la biondina.
Via la tuta, via le scarpe da tennis, e sotto con l’abbigliamento tattico: né ricercato né trasandato. Maglia, maglione e jeans, cappotto e sciarpina. Prima, però, una bella doccia e boxer freschi, ché non si sa mai.
Mentre andavo in macchina i pensieri mi si accavallavano. Che fai, Ale, le paghi il biglietto? Non sarà una di quelle che ci resta male? Fa’ così, ognuno si paga il cinema, ma tu le offri qualcosa al bar. Ecco, quello mi sembrava un giusto compromesso tra la galanteria e il non eccessivo corteggiamento.
E così era andata: lei si era fatta offrire popcorn e Coca-Cola. Ci eravamo seduti, lei alla mia sinistra, e avevamo chiacchierato del più e del meno prima dell’inizio del film. Io mi tenevo ben lontano dall’argomento lavoro. Sai mai che mi chiede una traduzione volante pure oggi… Anzi, aspettavo che introducesse lei i temi di discussione.
Avevamo parlato di noi. Le avevo detto che vivevo ancora a casa con i miei, aveva voluto sapere i nomi dei miei fratelli, e mi aveva raccontato di avere una sorella, molto più piccola, dal secondo matrimonio di suo papà.
«Si chiama Linda, non ha neanche due anni».
«Wow, figata» avevo esclamato io, visto che invece noi quattro fratelli siamo racchiusi in cinque anni e due mesi.
La serata si preannunciava piacevole, senza particolari colpi di scena: un primo appuntamento molto tranquillo. Mesi dopo avrei scoperto che quella domenica sarebbe dovuta andare diversamente, secondo i suoi piani. «Posso svelarti un segreto?» mi aveva detto.
«Ma certo».
«La domenica del cinema, quando siamo andati a vedere Le fate ignoranti».
«Eh, allora?».
«Sei stato il quarto o quinto ragazzo che ho chiamato. Solo che gli altri non potevano, e io non volevo andarci da sola».
Che faccia tosta…
Mi ero preso una pausa, prima di sparare la frase del secolo: «Be’, sai che ti dico? Sticazzi!».
Lei era scoppiata in una fragorosa risata. E io ero felice, perché quando rideva era ancora più bella.
Dopo il film non era successo granché. Avevamo fatto due passi chiacchierando della trama, della regia di Özpetek, dei suoi personaggi sempre così particolari.
Mi sentivo bene, mi piaceva parlare con lei, e già sapevo che quella volta non sarebbe successo altro, ma non era un problema. L’avevo accompagnata fino alla portiera della sua Clio bordeaux con una fiancata un pochino ammaccata.
«Allora io vado, che domani ho il turno delle sei» aveva tagliato corto lei, ma senza freddezza.
«Certo. È stato un bel pomeriggio, grazie. Passa una buona serata».
Poi aveva avuto una piccola esitazione, prima di inserire la chiave nella serratura.
«Senti, in settimana, se sei libero, perché non andiamo a vedere una mostra? Poi magari ci prendiamo un aperitivo».
Allora si era trovata bene, no?
«Splendida idea, giovedì ho il turno al mattino, per cui alla grande».
Poi i nostri occhiali si erano sfiorati, producendo un impercettibile tic tic durante lo scambio di baci sulle guance.
La mostra era di Kandinskij, e lì per la prima volta in vita mia avevo fatto lo splendido. Dato che avevo studiato russo per qualche anno all’università e poi all’associazione Italia-Russia, mi ero avvicinato con aria seriosa a un’opera, avevo scrutato la targhetta in carattere cirillico e poi avevo scandito con tono profondo: «Il titolo di quest’opera è Composizione numero 7».
«Wow, ma sai il russo?».
E io, come se fosse una cosa qualunque tra le mille che sapevo: «Mah, un pochino, dài, giusto le frasi basilari».
«Che figata! Sai l’inglese e il russo».
Shh, Ale, non aggiungere una parola: dieci punti per te e zitto.
Mi sentivo importante. Ecco cosa. Mi metteva lì, al centro delle sue attenzioni. Mi faceva sentire speciale.
Il resto della serata era stata una favola. Innaffiata però di alcol: Negroni sbagliato, per la precisione. Tre a testa, al Victoria, dietro al teatro alla Scala. Peraltro senza una vera cena, ma spilluzzicando da uno di quei buffet milanesi messi insieme riproponendo i rimasugli di pizzette e tramezzini avanzati dal pranzo, qualche oliva, pezzetti di focaccia e un paio di verdure in pinzimonio per illudersi di trattare bene il proprio corpo.
Poi barcollando l’avevo accompagnata alla mac- china.
«Ehi, Del Rouge, stavolta non ci sono turni delle sei, o sbaglio?».
«Ah ah, come mi hai chiamata?».
«Non ti piace? Un po’ di arte, suvvia. Siamo reduci da Kandinskij, non ti senti un po’ a Parigi, sulla Rive Gauche? E comunque non tergiversare. Niente fretta, no?».
«Sali in macchina».
Era stato un ordine pronunciato con dolcezza, ma con un non so che di perentorio. E io non l’avrei mai contraddetta. Non c’era stato bisogno di tante altre parole.
«Del Rouge, vieni qui».
Era arrivata. Le sue labbra, subito. La sua lingua. Le mani ovunque, gli occhiali che erano caduti. I miei prima, i suoi subito dopo. Sapore di alcol in bocca, di adrenalina. Poi, occhi negli occhi, il mio azzurro, il suo blu. Una risata.
«Che cazzo ti ridi, Del Rouge?».
Ma non riusciva a trattenersi.
«Ora ti sistemo io».
E nuovamente un bacio, prima delicato, poi profondo, appassionato, interminabile.
Ci eravamo staccati, minuti dopo. Appagati.
«Senti, la macchina la lasciamo qui, vero?».
«Forse è meglio» aveva detto lei. «Però ognuno a casa sua».
«Cheppalle. Come vuoi».
Per quella sera era andata bene così.
* * *Sono nel parcheggio dell’ospedale, vorrei correre, scappare da qui, gridare. Vorrei lasciarmi tutto alle spalle, mettermi al volante e andare, andare, andare senza meta. Come se allontanandomi potessi cancellare con una bacchetta magica tutti i pensieri più cupi. Invece rimango impietrito davanti alla macchina, incapace di muovermi, come se da quella maledetta clessidra fosse uscita una tonnellata di sabbia che mi àncora i piedi. Devo tornare dai bambini ma il cuore mi tira verso Francesca.
Tra un mese, al massimo tre, dunque.
Ripenso alla dottoressa e non riesco a trattenere un moto di rabbia. Ma non ce l’ho con lei per essere stata così diretta e brutale: non mi ha mentito. D’altronde, come si dice a qualcuno che un suo caro sta per morire? Non esiste un modo gentile, perché anche se tutti sappiamo che prima o poi ce ne andremo, non è piacevole sentirselo ricordare.
Se ripenso alle parole che mi ha detto poco fa, il punto è un altro: sto già versando fiumi di lacrime per un addio annunciato, quando però i medici mi hanno detto che c’è ancora una cura da provare come ultima spiaggia.
Sì, perché come disperato tentativo di fermare il tumore, penetrato nel sistema nervoso centrale, hanno deciso di fare delle iniezioni intratecali di farmaco chemioterapico direttamente nel midollo. Le donne che hanno partorito e hanno fatto l’epidurale sanno cosa significa: un ago nella schiena, tra una vertebra e l’altra. Con la differenza che l’epidurale, nel caso del parto, serve ad attenuare un dolore che prelude alla nascita, qui è l’ultimo baluardo davanti alla morte.
Dopo la prima, Franci lo aveva sottolineato: «In fondo è una puntura come quando sono nati Angelica e Mattia». Ma nel pronunciare queste parole gli occhi le si erano riempiti di lacrime. Io, abbracciandola: «Dài Franci, se poi sarà efficace dimenticheremo anche questa».
Un mese, al massimo tre. Se davvero siamo all’ultimo chilometro, allora che senso hanno queste punture? Non sarà accanimento terapeutico?
Arrivo a casa con una sensazione nel cuore di devastazione mista a rabbia. Telefono al mio amico Dario. Lo chiamo il mio “testimone di nozze virtuale”, perché la sera dell’addio al celibato si è rotto una mano giocando a calcetto, si è operato proprio il giorno delle nozze e ho dovuto sostituirlo in corsa.
Gli racconto tra le lacrime che ormai è finita, e lui si fionda a casa mia.
«Amico mio».
Mi saluta sempre così.
«Ci siamo, Dario. Stavolta non ce la fa. Non ce la fa».
Non ha molto da dirmi, ma è qui, mi dispensa abbracci. Mi fa capire che c’è, al mio fianco. Ed è quello che conta.
Non so bene con quali parole riesco a riassumergli la giornata.
«E allora» mi consola, «se così deve essere, vuol dire che ce la faremo noi, insieme».
Ci abbracciamo. Poi lui aggiunge: «Ale, perché non chiami quel dottore di cui mi hai parlato così bene? Ti fidi ciecamente di lui, magari saprà dirci cosa sta succedendo».
* * *Il giorno del nostro primo bacio era un giovedì. Era il 26 aprile.
Il venerdì mattina ero in Brianza, a casa del mio amico del calcetto, e mentre tenevo a bada i sintomi della sbronza mi sorbivo la seconda razione di insulti per aver fatto saltare la partita la domenica precedente.
«Sergio, non ne sono ancora sicuro ma forse devo andare in montagna con una collega, mi servirebbe qualche ciocco per il camino».
Infatti dopo il bacio mi ero lanciato: «Senti, Del Rouge, ho sbirciato i tuoi turni, so che non lavori il weekend. Neppure io. Allora ho pensato che potremmo andare in montagna, nella casa dei miei, in Valtellina».
E che cazzo, tu hai scelto film, cinema e ora? E io ti piazzo lì un fine settimana intero.
Lei, che era sempre abituata a tenere in mano il pallino del gioco, quella volta aveva esitato: «Come dire: vai veloce tu eh. Posso pensarci?».
«Certo, pensaci. Ovvio. Puoi dirmelo anche all’ultimo».
Proprio mentre il mio amico imprecava, «prima non ti presenti, adesso pure la legna», era squillato il cellulare.
«Ale?».
«Ehi, Franci».
«Io stasera finisco di lavorare alle sette. Se sei ancora dell’idea, partiamo».
“Ancora dell’idea”? Forse non aveva capito che stavo già facendo provviste…
«Ma certo. Passo da te alle otto e in due ore siamo su».
Prima di arrivare nella casa dei miei a Tresivio ci eravamo fermati a mangiare una pizza a Piateda, un paesino lì vicino in provincia di Sondrio dove ho passato le estati dell’infanzia. Avevo percorso lentamente la strada che taglia in due l’abitato, passando davanti al New Mexico, una delle discoteche più bazzicate della valle, trenta e più anni fa. Poi avevo girato a destra, anziché proseguire per Boffetto, e al bivio mi ero lasciato alle spalle l’indicazione per Piateda Alta e mi ero diretto verso la frazione di Valbona, per respirare l’aria di quando ero bambino. Intanto, facevo la guida turistica di questo posto sperduto: «Lì, in quel campo che costeggia il fiume Adda, ho messo gli sci ai piedi per la prima volta. Facevo con i fratelli venti metri in discesa, tutto dritto, e mi sembrava di essere Ingemar Stenmark. Guarda, lassù in quel bosco c’era la capanna dove ci rifugiavamo a leggere i fumetti. Qui invece abitava la matta del paese, chissà se è ancora viva…». Percorrevo stradine asfaltate senza un nome e la mettevo a parte dei miei anni più spensierati, quelli delle discese in bob dai sentieri stretti, delle scorribande a cercare mirtilli o funghi porcini e giallini, dei giochi nei campi di grano.
Arrivati a casa erano state ore di camino acceso, coperta sulle spalle e chiacchiere, fino alle tre di notte. Poi, esausti, eravamo andati a dormire.
«Franci, se vuoi stiamo in camere separate».
«Ma sei fuori?!».
Ci eravamo addormentati subito, sfiniti. Tutta la notte abbracciati. Non avevamo fatto l’amore, e neanche al mattino, visto che lei se l’era ronfata di brutto. Io a un certo punto mi ero alzato di soppiatto ed ero sceso in paese a comprare il necessario per la colazione a letto. Non sapendo cosa preferisse, al bar avevo preso di tutto: brioche vuote, alla marmellata e al cioccolato, due o tre succhi ai gusti vari, latte, biscotti. Già che c’ero ero andato dall’ortolano e avevo riempito un sacchetto di frutta. Avrei potuto sfamare un esercito.
«Ma che è?!» erano state le sue prime parole appena aveva aperto gli occhi e visto quel ben di Dio.
«Ma che ne so, ho improvvisato…».
«Io di solito prendo un caffè e basta. Però dài, stavolta farò un’eccezione».
Avevamo fatto l’amore solo dopo pranzo. Poi per anni avremmo scherzato sulle improbabili proprietà afrodisiache dei pizzoccheri. Altro che ostriche, peperoncino e cioccolato.
La sera, a letto, sgranocchiavo una mela. Arrivato fino al torsolo, mi ero ritrovato qualcosa in bocca e allora l’avevo tirata verso di me con fare malandrino e fintamente sensuale, poi… Ptuuu, le avevo sputato il semino in faccia, centrandola sul naso. Avevo riso come un ebete, e lei aveva promesso vendetta – «sì sì, vedrai» – divertita dalla mia cretineria.
Il giorno dopo, all’alba lei si era avvicinata con occhi da gattona, e mentre io mi scioglievo dentro quello sguardo… Trac, mi aveva infilato nell’orecchio il semino che aveva debitamente conservato per tutta la notte sul comò, avvolto in un pezzetto di carta igienica.
«Ma sei scema? Così si può finire all’ospedale!».
Che tipino, ’sta Del Rosso.
A un certo punto dalla radio accesa era partita una canzone:
“Now I’ve had the time of my life
No I never felt like this before…”.
«Oddiooo!». Lei era arrivata dall’altra stanza con le mani nei capelli.
«Oh, che succede?».
«Ti prego ti prego ti prego! Mettiti là».
«Ma là dove?».
«Zitto, Johnny, vai là che faccio Baby».
«Chi?! Ma sei impazzita?» avevo detto io sempre più confuso.
«Cazzo! Dirty Dancing… Forza, veloce che mi devi prendere e facciamo la scena madre».
Mi ero spostato, mentre purtroppo iniziavo a capire, e avevo raggiunto il tappeto vicino al camino. «Qui?».
«Dài dài che sta arrivando il punto della canzone. Ora io corro, poi salto e tu…».
«…».
«Minchia non ti ricordi il finale di Dirty Dancing, Milan?!».
«Ma sì qualcosa ricordo…».
«Ecco, allora Baby prende la rincorsa e tu la sollevi, ben sopra le spalle. Ma bene in alto eh!».
«Ma sei sicura?».
«Eccomi che parto, mi raccomando eh!».
Era partita dalla cucina, aveva fatto un salto di dieci centimetri, a essere generosi. Inoltre io ho sempre avuto la forza muscolare di un canarino. Ma, anche se goffamente, ero riuscito ad alzarla un poco.
«Ecco, eccooo. Più suuu!». Aveva allargato le braccia come Jennifer Grey nel film. «Guardami! Guardami, sono una farfalla! Volooo!».
«Ma quale farfalla… Non ce la facciooo…».
Ed eravamo franati a terra, Johnny e Baby, come due deficienti.
Eravamo tornati a casa domenica sera. Io felice, lei arruffata e senza pensieri. Però mi aveva squadrato, poco prima che la lasciassi sotto casa, e imperiosa aveva detto: «Mi devi promettere una cosa».
«Dimmi» avevo sorriso.
«Guarda che sono serissima».
«Avanti».
«Non ne devi parlare con nessuno in radio. Nes-su-no, capito?».
«Ok, figurati».
«No, davvero. Non voglio casini sul lavoro. Intesi?».
«Agli ordini».
* * *Dario mi guarda mentre Marco, il neurochirurgo, al telefono centellina le parole. Gli racconto del dialogo avuto con la dottoressa, della sua perentoria diagnosi, e gli chiedo senza mezzi termini se siamo davvero alla fine. Gli dico che in nome del nostro rapporto deve essere sincero. Voglio sapere.
Si capisce che è nella spinosa situazione di chi vorrebbe dire peste e corna della collega, che forse si è fatta sfuggire una frase di troppo, ma sa che è meglio non alimentare tensioni.
«Non è accanimento, Ale, su questo voglio rassicurarti. Mi sentirei uno sciagurato a perseguire un accanimento nei confronti di Francesca. La situazione è difficile, sì. Drammatica, forse. Ma una strada c’è. E finché c’è, il dovere del medico è percorrerla. È strettissima, un sentiero impervio, d’accordo, ma esiste».
Al solito è bravissimo a dosare le parole, a spiegare con semplicità le situazioni mediche più complicate, a rincuorare.
«Vedi, Ale, come spesso accade, non c’è il bianco e il nero, ma solo sfumature di grigio».
Io però stasera sono una tigre in gabbia. Dario mi vede camminare su e giù al telefono, sta seduto sul divano ma scruta ogni mio movimento, cerca di capire qualcosa dalle mie reazioni e dai miei occhi. A un certo punto si alza, mi raggiunge, mi mette una mano sulla spalla e cammina per un tratto su e giù con me.
«Marco, gli oncologi hanno detto che deve fare questa puntura spinale ogni quindici giorni, però la radioterapia è esclusa perché aumenterebbe la tossicità, hanno sospeso il farmaco sperimentale e parlano anche di altra chemio in vena».
«Capisco».
«Questa cosa della chemio ha abbattuto molto Franci. Anche io, te lo confesso, sono perplesso. Cioè, ancora la chemio? Ma perché? Dimmi».
«Ale, queste punture intratecali possono avere una loro efficacia nel rallentare il tumore. Certo, è difficile rispondere alla tua domanda, credimi. Però ti faccio una promessa».
«Ti ascolto».
«La situazione è quella che ti ho spiegato. Ma con la stessa certezza con cui non ti prendo in giro dicendoti la verità ora, aggiungo che nel momento stesso in cui dovessi accorgermi che non ci sarà più niente da fare, ti guarderò negli occhi e te lo dirò. Però promettimi anche tu una cosa».
«Quello che vuoi».
«State vicini. E cerca di donarle tutti i sorrisi che puoi, tutti quelli che si riescono a rubare ai pensieri più brutti».* * * * *
Mi vivi dentro
È il 14 dicembre 2016 e siamo appena tornati dal funerale. Non so cosa possa voler dire per due bambini di dieci e otto anni vedere la loro mamma in una bara. È vero che i bambini sanno reagire a qualsiasi situazione, anche la più negativa, con risorse inimmaginabili per un adulto, ma la giornata deve essere stata terribilmente pesante per loro. Fortunatamente alla cerimonia hanno partecipato anche tutti i compagni di classe, preparati da maestre e maestri con una dedizione e una cura straordinarie. Non hanno lasciato Mattia e Angelica per un solo secondo, se li sono coccolati anche durante la messa, tenendoli dietro all’altare. Poi, terminata la funzione, nell’oratorio a fianco hanno lanciato una serie di palloncini in cielo perché potessero raggiungere Franci in Paradiso.
Ora siamo a casa.
Squilla un telefono.
Non è il mio e neppure il fisso.
Ci metto un attimo a capire.
Oddio, non ci credo, ma questo è…
Getto lo sguardo verso il mobile in sala. Appoggiato su uno scaffale c’è il cellulare di Francesca, che ho inavvertitamente lasciato acceso.
Ma chi sta chiamando su quel numero?
Mi avvicino e guardo il display.
“Casa”.
Qualcuno sta chiamando Franci da casa?!
Realizzo con un istante di ritardo.
Prendo in mano il telefonino e mi dirigo verso la nostra camera. Poco prima di entrare, schiaccio sul rosso per rifiutare la chiamata.
Trovo Angelica seduta sul letto, di spalle. È in silenzio, il cordless all’orecchio. Probabilmente si sta domandando perché il cellulare di mamma stesse suonando, magari spera che lei risponda, per una qualche improbabile magia.
«Angie…».
Non dice niente, gli occhi riversi in basso, a scrutare il parquet.
Mi siedo di fianco a lei sul lettone.
«Piccola, scusami, è colpa mia, l’ho lasciato acceso senza rendermi conto. Il numero è ancora attivo, è per questo che squilla. Ma come sai la mamma non può più rispondere».
Silenzio. Lo sguardo non si smuove dal pavimento.
«Angie?».
«Io non viaggerò mai più, senza la mamma».
La frase mi spezza lo stomaco. I viaggi. Proprio il nostro amore, la nostra passione, i sogni di tutta la famiglia a ogni estate e ogni inverno frantumati così, poche ore dopo il funerale.
No, Angelica, i viaggi no, puoi piangere, disperarti, imprecare, persino insultarmi se vuoi, ma i viaggi no. Perdere l’amore per l’esplorazione significa perdere la voglia di vivere, significa gettare alle ortiche anni di educazione, di crescita, di apprendimento, di tutto.
Devo reagire, e subito. Anche perché mia figlia ha pronunciato queste parole senza sollevare lo sguardo da terra, come una sentenza. Inappellabile. Una sentenza alla Del Rosso.
Devo tirare fuori un coniglio dal cilindro. E non domani, non tra un’ora. Ma adesso, su due piedi.
Ok, ci provo.
«Pensa, Angelica, che io invece, giusto cinque minuti fa, stavo proprio pensando a un viaggio».
Silenzio, non smuove gli occhi dal parquet.
«Sai, la mamma aveva un sogno, e questo sogno si chiama Maldive. Avremmo voluto portarvi lì, prima o poi. È un posto meraviglioso, con un mare incontaminato, pesci coloratissimi, il cielo blu come non l’hai mai visto».
Niente. Non si scuote.
«E allora pensavo: perché non ce ne andiamo alle Maldive io, te e Mattia? Subito, a Natale! Un viaggio tutto nostro. Anzi, sai che ti dico, partiamo proprio il 25, così il Natale lo festeggiamo in volo, vicino al Paradiso, vicino alla mamma».
Parlo da due minuti, ma Angelica non si è ancora mossa. Ha solo appoggiato il telefono sul letto, ma senza pronunciare mezza parola.
«Senti, piccola mia, ora non ci pensare, guarda un po’ la TV. Ti prometto che stanotte dormiremo abbracciati, ok?».
È una notte strana, tutti e tre nel lettone, io con la testa cupa e piena di pensieri, loro i soliti angioletti, con il sonno profondo e chissà quali sogni.
Le Maldive. Cosa diavolo mi è venuto in mente? Un viaggio del genere, da solo con i bambini, appena morta Franci.
Eppure il desiderio c’era davvero. Me l’ha messo in testa Silvia, la chirurga plastica di Franci, che io chiamo la “Doc”. In ospedale, uno degli ultimi giorni di vita di Francesca. Mi ha preso da parte e mi ha detto che anche lei ha perso sua madre troppo presto. Perciò ci teneva a darmi un consiglio: «Quando tutto sarà finito, fate un viaggio voi tre. Per isolarvi dal mondo, per staccare da qualunque cosa. Mio padre ci portò a Vienna, appena morta mamma. Ancora oggi, a distanza di anni, ricordo quel viaggio come qualcosa di speciale».
Già, ma Angelica l’ha presa malissimo, mi pare di aver capito. Le ho parlato delle Maldive e non ha aperto bocca. Ha ascoltato, sì, poi si è alzata ed è andata a vedere un cartone animato. Tutto in silenzio. E quella sentenza, “non viaggerò mai più, senza la mamma” pesa come un macigno sulla mia anima. Forse il motore della famiglia si è rotto definitivamente. La macchina è guasta, le ruote non rispondono più, e andremo a sbattere. È la fine?
I pensieri senza sosta mi fanno trovare il sonno soltanto a notte fonda, per cui quando mi sveglio i bambini sono già in piedi e stanno facendo colazione. Citofona un’amica che è venuta a controllare come stiamo. Entra in casa, non fa in tempo a salutarmi che Angelica le si fionda addosso: «Ciaooo! Ma sai che c’è una bellissima novità?».
«Cosa, Angie?».
«Papà ci porta alle Maldiveee! A Natale andiamo alle Maldive! Ed è pieno di pesci colorati, il mare è bellissimo, e sai poi ci sono gli squali, le tartarughe. Partiremo a Natale, e sarà bellissimo!».
Angelica è un fiume in piena, sogna e racconta, parla e ride, con la mente è già via, con le gambe danza sulla sabbia bianca e fine.
Possiamo ripartire da qui, subito. Possiamo iniziare a camminare. Mi torna in mente la frase che ho scritto d’istinto su Twitter poche ore dopo la morte di Franci: “Non piangete, lei non avrebbe voluto. Grazie a tutti. Ora inizia un percorso di dolore”. Tutti si sono concentrati sulla parola “dolore”, io preferisco “percorso”.
È tempo di ripartire, anche se può sembrare assurdo farlo ora. Leggo stupore negli sguardi delle persone, chissà forse qualcuno avrà pure storto il naso vedendo che la sera del funerale sono andato a bere qualcosa con i colleghi. È una tradizione, noi che purtroppo a Radio24 abbiamo pianto diverse perdite. L’ultima volta è successo per Fabio, per tutti “Rudy”, stroncato da un infarto nel pieno splendore dei suoi anni; siamo andati al Ganas, in corso Como, per alzare i bicchieri colmi di mojito. Lo abbiamo fatto anche ieri sera per la Franci, con i volti sorridenti, magari un po’ tirati, ma vogliosi di brindare alla vita. Rudy avrebbe voluto così. Franci avrebbe voluto così.
È ora dunque di mettersi in marcia. Lo zaino idealmente è già in spalla, infarcito di dubbi e ansie, ma pieno anche di sogni, aspettative e speranze. Ci sono tre biglietti aerei per le Maldive da comprare. Partenza il giorno di Natale, con passaggio vicino al Paradiso.
Oggi è il 15 dicembre, fuori c’è un sole limpido che a gustarselo scalda persino la pelle.
Sul molo dell’isoletta di Rannalhi, atollo a sud di Malé, tira un vento fresco. Mattia mi tiene la mano e cammina con il nasino all’insù.
«Papà, guarda quella stella. E quell’altra. E quella! Ma quante sono!».
«Eh, lo so Mattia, te l’avevo detto che alle Maldive il cielo è uno spettacolo anche di notte».
«Ma secondo te, quale di quelle è la mamma?».
«Scegline una, Matti. Quella che ti piace di più».
«Mmm… quella!».
Punta il dito verso l’alto, a destra.
«Ok, d’accordo allora. Mi sembra anche bella luminosa, no?».
«Che peccato però, che non ci sia. A lei piaceva fare snorkeling».
«Sapete che vi dico? Domani sera andiamo a pescare al tramonto. Mi sono già iscritto».
«Evvai!» esulta Mattia.
«Papà, ma non sappiamo pescare» fa notare sua sorella.
«Ma che ti frega» le risponde lui, «si va con i pescatori del luogo, ci danno rocchetto e filo, ci mettono pure l’esca direttamente sull’amo, devi solo buttare in acqua e aspettare».
È sempre la più timorosa, Angie, all’inizio ha bisogno di una spinta.
Poi però è anche quella che nel tramonto maldiviano pesca per prima.
«Papààà!» urla quando sente che qualcosa ha abboccato.
«Tira su, tira su!» la incitiamo in coro.
La barca si muove, arriva anche il pescatore a dare man forte.
«Forza, Angie, guarda come tira! Eccolooo!».
«Red snapper». Il capitano della barca guarda la bambina e fa il pollice in alto. «Good. Red snapper!».
Poi è la volta di Mattia.
«Don’t touch!» gli dice quando lo tiriamo fuori dall’acqua.
«Ecco, Matti» mi metto a ridere, «ne hai preso uno velenoso».
Fa il faccino un po’ deluso.
«But tasteful, very tasteful».
«Capito, campione?». Traduco: «Non si può toccare però è buono da mangiare. Bravo!».
Alla fine pure io riesco a prendere i miei due pesciolini.
Poi arriva la notte di Capodanno, tutti a mangiare con i piedi nella sabbia, sotto il cielo stellato. Ora percepisco per la prima volta la tristezza di una festa senza Franci. Lei, con la sua voglia di vedere il bicchiere sempre mezzo pieno, meglio se di mojito, ora non c’è. Anzi, non tornerà mai più. So già cosa avremmo fatto: avremmo riso del vestito di quella strappona indiana, avremmo commentato l’acconciatura improbabile di quelle tardone, forse inglesi. Mi avrebbe anche stuzzicato sul culo di quella francese, e io avrei glissato con un “sì, niente di che” al quale lei avrebbe replicato con il classico “va’ che ti controllo, pirletta”.
La cena finisce alle dieci e mezza.
«Papà, ho sonno».
«Lo so Mattia. E tu Angie?».
«Pure».
«Andiamo a nanna?».
«Sì».
E così a mezzanotte, mentre in lontananza qualcuno fa scoppiare qualche mortaretto e il gruppo sul palco intona un’improbabile melodia brasiliana, sono nel lettone con i miei figli. Loro ronfano già, io guardo in TV una partita di Premier League.
Auguri, Franci. Ovunque tu sia.