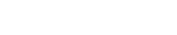Nell’estate del 1998 era ormai chiaro che il mio udito aveva qualcosa che non andava. Non avvenne all’improvviso – non passai dal cento al settanta o al cinquanta per cento nel giro di una settimana – ma pian piano, talmente piano che quasi non mi accorsi che stesse accadendo, il suono si dileguò. Non fu accompagnato da nessun dolore, nessun suono del suono in ritirata, solo la graduale consapevolezza di un’attenuazione.
A gennaio ero ancora in grado di udire il traffico proveniente dalla strada. A marzo riuscivo a sentire alcune “interiezioni sonore” – una porta che sbatte, un clacson che strombazza – ma non i rumori che le legavano. I rumori che prima erano nitidi sembravano ovattati, le frasi un tempo separate da chiare linee di demarcazione ora apparivano sbavate. In assenza dell’articolazione del parlato – le sibilanti, gli angoli e le svolte, la segnaletica verbale – non riuscivo a orientarmi. Negli eventi sociali, dominati da una specie di basso sciabordio, continuavo ad allacciarmi alle frasi sbagliate. Dove una volta mi destreggiavo con facilità, ora collezionavo una gaffe dietro l’altra.
Per qualche tempo mi comportai come avrebbe fatto qualsiasi adulto ragionevole e assennato nella mia situazione: ignorai il problema. Quando non fu più possibile, fissai una visita dal medico di base, che mi indirizzò al reparto di audiologia del St Mary’s Hospital di Londra.
L’audiologo, Steve, era sulla quarantina. Portava scarpe rosa e una cravatta con un disegno di Scooby Doo. La sua pelle emanava la leggera luminescenza di chi vede poco la luce del giorno e ha fatto della spossatezza il suo stile di vita. Dopo l’anamnesi mi fece entrare in una cabina insonorizzata a cui erano appese un paio di cuffie e poi prese posto in un gabbiotto pieno di quadranti e macchinari.
Accese un interruttore e nelle cuffie comparve la sua voce. «Faccia un cenno con la testa quando sente qualcosa.»
Dopo un paio di secondi sentii un basso suono elettronico, un’unica nota. Avendolo sentito, annuii. Il suono successivo era forse quattro toni sopra. Feci un altro cenno con la testa. Andò avanti così, risalendo tutta la scala, dai gravi agli acuti. Di fronte a me vedevo Steve che appuntava i risultati.
«Ecco qui», disse una volta concluso l’esame, passandomi un paio di fogli su cui erano stampati due grafici, uno per l’orecchio destro e l’altro per il sinistro. In ogni grafico sull’asse verticale erano indicati dei numeri da 0 a 100, con una linea nera nel mezzo che partiva dal 50. Sull’asse orizzontale erano presenti otto linee di uguale spessore, ciascuna corrispondente a un aumento progressivo del volume. Steve aveva tracciato a matita una linea che collegava i segni precedentemente annotati, in cui spiccava il punto esatto in cui il suono era divenuto udibile. Entrambe le linee avevano un andamento a zigzag, ma nessuna sembrava corrispondere al cento per cento.
Guardai prima i grafici e poi di nuovo Steve.
«Non è il massimo», disse. «Non so esattamente quale sia la situazione perché il quadro è contraddittorio, ma sembra che il trauma cranico di cui mi ha parlato possa aver esercitato una pressione sul lobo temporale. Il cranio è stato spinto in basso verso la spina dorsale, il che ha creato una tensione in tutti i muscoli del collo, riducendone la mobilità. Il che a sua volta implica che tutti gli ossicini dell’orecchio si sono spostati, e se questi ossicini non si muovono bene, non riescono a trasmettere il suono come dovrebbero.»
«Insomma, un collo di bottiglia», dissi io.
«Qualcosa del genere.»
«E se si riuscisse a ridurre questa pressione, andrebbe meglio?»
Steve mi guardò. «Non credo», disse. «La configurazione della sua ipoacusia è incoerente, ma da quello che posso vedere sembra esserci un danno alle cellule ciliate della coclea. Quindi dubito che se anche si riuscisse a raddrizzare il collo la situazione migliorerebbe.»
«Ma se gli ossicini tornassero a muoversi…»
«Probabilmente ormai il danno è fatto.» Sulla sua scrivania c’era la sezione di una testa umana di genere indefinito, un modello in plastica primaria che mostrava la parte laterale del cranio e l’anatomia dell’orecchio. La prese in mano e indicò una zona rossa.
«Ha idea di come funzioni l’udito?»
A scuola, nelle ore di biologia, avevo imparato che l’orecchio ha una sezione interna, una media e una esterna, ma le mie conoscenze si fermavano lì. «No», risposi.
Steve indicò un’area del modello prossima al centro del cranio. «Il problema è che gran parte del processo uditivo ha luogo in una parte del corpo a cui non abbiamo accesso. Se ci si frattura una gamba, si può fare una radiografia. Per il cancro viene prescritta una biopsia o una TAC. Nella maggior parte dei casi si può ottenere un’immagine fisica di ciò che avviene all’interno del corpo. Ma con l’orecchio questo non è possibile. Si può fare una risonanza magnetica, ma anche così non si riescono ad acquisire molte informazioni. Se si fosse perforata il timpano, potremmo osservare il danno da fuori perché riguarda l’orecchio esterno, ma non è possibile vedere dentro l’orecchio interno, perché si trova proprio in fondo al cranio, dove è incastonata una minuscola spirale, la coclea.»
Posò il modello davanti a me sulla scrivania. «Non possiamo fare altro che esaminare gli indizi forniti dall’audiogramma e, dalla sua configurazione, avanzare un’ipotesi ragionata sulla situazione. Di solito si tratta di un’ipotesi piuttosto precisa, ma è pur sempre un’ipotesi, perché lì dentro di fatto non si riesce a vedere. E, in generale, proprio per questo, una volta che si danneggia qualcosa nell’orecchio interno, il danno resta. Nella maggior parte dei casi non si può intervenire, perché l’orecchio interno si trova a una tale profondità che non si tratterebbe più di chirurgia dell’orecchio, ma di neurochirurgia.»
Si fermò per darmi il tempo di elaborare quel concetto. «Il dato positivo è che sulle alte frequenze il suo udito è ancora accettabile.»
Lo guardai come imbambolata.
«Sa», disse, «la perdita dell’udito non avviene con un passaggio improvviso dall’udito perfetto al silenzio totale. L’udito non è qualcosa che prima si ha e poi non si ha più. O comunque normalmente non è così che accade. Tutti sentiamo una certa gamma di frequenze, da quelle più basse a quelle più alte. In condizioni ottimali – di solito in giovane età – l’orecchio umano può percepire i suoni con frequenze da venti hertz a venti kilohertz. Ma questo accade raramente. Di solito, o perché si invecchia o perché si è così stupidi da andare ai festival e avvicinarsi troppo agli altoparlanti, l’udito inizia a perdere colpi. Ma il danno non riguarda tutte le frequenze.»
Ruotò il modello di plastica in modo da averlo di fronte e indicò una minuscola spirale a forma di conchiglia in fondo all’orecchio interno. «Sa com’è fatta la coclea?»
Scossi la testa.
Lui restò per un attimo con il dito puntato. «La coclea è minuscola. Non è più grande di un seme di girasole, ma possiede migliaia di cellule chiamate stereociglia, che si muovono quando percepiscono le vibrazioni sonore. Siccome sono dritte come i peli di un tappeto, vengono chiamate cellule ciliate. Le cellule ciliate che rispondono alle alte frequenze si trovano nella parte anteriore della spirale, mentre quelle delle frequenze basse sono collocate al centro, per cui anche i suoni a bassa frequenza devono passare dalle cellule ciliate dell’alta frequenza prima di raggiungere le altre.»
Annuii. Non capivo molto, ma meglio mostrarsi attenti.
«E visto che le cellule delle alte frequenze sono molto più sollecitate, tendono a logorarsi più rapidamente. Provi a immaginarle come un tappeto. È ovvio che si consumerà più nelle parti soggette a usura che nelle altre. Quindi prima si perdono le frequenze alte, poi le intermedie e infine le basse.»
Indicò di nuovo la parte superiore dei due grafici dell’audiogramma. «Lei non sembra aver perso molto nelle alte frequenze, ma in media, nell’insieme, la perdita si aggira tra il quaranta e il cinquanta per cento della normale capacità uditiva.» Poi si bloccò, continuando a guardare il foglio. «Mi sorprende che abbia sopportato questa situazione per tanto tempo.»
«Ma ho ventisette anni», dissi io. «Perché sto perdendo l’udito?»
«Forse perché continua a sbattere la testa», rispose lui sorridendo.
Ricambiai il sorriso, decisa a restare allegra.
«Se lei fosse un uccello», disse lui, «sarebbe diverso. Negli esseri umani le cellule ciliate non si rigenerano. Sono quelle e basta. Ma negli uccelli, se si distruggono, poi possono ricrescere. Perché se gli uccelli non sentono i loro simili, non possono accoppiarsi, e se non si accoppiano la specie si estingue. E naturalmente è sempre utile sentire un predatore che si avvicina di soppiatto. Anche se dovessero distruggersi tutte le cellule ciliate, poi ricrescerebbero. Gli uccelli recuperano l’udito nel giro di un mese.»
A me gli uccelli non interessavano. Piuttosto, mi interessava sapere se la situazione sarebbe migliorata o no, e ora sapevo che la risposta era negativa. Non avevo mai sentito parlare di cure per la sordità. Per la sordità non c’era cura.
Steve mi guardò e per un attimo nei suoi occhi vidi l’inizio di un’altra conversazione, una conversazione basata sulla compassione e su una sorta di comprensione. Poi diede un’occhiata allo schermo e tirò indietro la sedia.
«Guardi», mi disse, «mi rendo conto di averle dato tante informazioni da elaborare. Ma per il momento la cosa da fare è mostrare i risultati al dottore. Poi le installeremo un apparecchio acustico.»
Nel 1990 ero andata a sciare con un gruppo di amici dell’università. Qualcuno era riuscito a trovare un’offerta economica di fine stagione in una delle grandi località sciistiche francesi, un pacchetto all-inclusive che comprendeva un appartamento autonomo e un servizio navetta per le piste. Prenotammo per fine marzo e, al di là delle diverse abilità sciistiche, fremevamo tutti per la partenza.
Solo quando l’autobus si avvicinò allo skilift ci accorgemmo che non c’era neve. Niente di niente, neanche un fiocco. Economico, in questo caso, voleva dire a secco. Su in montagna il suolo era brullo e piatto, il marroncino della pelle appena conciata. Più giù cominciava già a ricrescere l’erba, ombreggiando di un verde fresco quelle che dovevano essere le discese per principianti. Fuori dai grandi alberghi i bucaneve erano fioriti e sfioriti e già le giunchiglie spuntavano sul ciglio della strada. Ci rilassammo per un attimo al suono dell’acqua del disgelo tornata a scorrere nei fossi.
«Be’, pazienza», disse Clare, che era seduta accanto a me. «Che ne dite di un giro sui pattini?»
Un autobus italiano accostò vicino a noi. Dai finestrini osservammo la reazione dei passeggeri, identica alla nostra: sgomento, risate, un chiacchiericcio animato.
Non aveva senso restare lì, così uscimmo per scaricare i bagagli.
«Pas de neige?» chiesi alla donna che ci consegnò le chiavi dell’appartamento, indicando fuori. «Où est la neige?»
La donna sorrise. «Pas de problème!» Gesticolò per indicare una specie di stradina bianca che si snodava giù per la montagna accanto allo skilift principale. A scintillare al sole non era l’ombra celeste polvere della vera neve, ma la tagliente rifrazione del ghiaccio. «Neige artificielle! Pour tous!»
«Oh, oui, d’accord!» convenimmo educatamente. «Absolument!»
La mattina dopo, muniti di sci e scarponi, ci mettemmo in marcia. Soltanto alcuni degli skilift più a valle erano ancora aperti e sulle piste attive c’era un sottile strato di permafrost compatto ricoperto da una spolverata di neve artificiale sparata di notte dai cannoni. I pisteurs le avevano percorse in lungo e in largo con gli spazzaneve, allineando il ghiaccio in fragili montagnette. Più su, qualche macchia di bianco non ancora sciolta dava un’idea di com’era quel luogo quand’era come doveva essere.
Malgrado ciò, le piste ancora aperte erano piene. Invece che palle di neve i bambini si lanciavano palle di fango, mentre i genitori prendevano il sole seduti al bar. Nel giro di due giorni ci abituammo al formidabile effetto frenante che dà scivolare dal ghiaccio alla terra, entrando e uscendo dai caffè con passo pesante in maglietta e crema solare.
Il terzo giorno decidemmo di comune accordo di spostarci in alta montagna. Nella funivia escursionisti in scarponi e giacche a vento ci rivolgevano larghi sorrisi o spiegavano cartine per illustrarci la rete dei sentieri. Persino lassù in vetta era aperta soltanto metà delle piste. Davanti a noi si spandevano in ogni direzione le grandiose cime frastagliate delle Alpi. I picchi delle montagne più alte erano ancora bianchi, ma, ovunque guardassimo, l’oscurità delle valli senza neve si insinuava quasi fino alle vette. Ci distribuimmo in gruppi, divisi per livello di preparazione sciistica. Tre di noi volevano capire se c’era qualche fuoripista in cui valeva la pena lanciarsi, mentre io volli provare una lunga pista rossa. Gli altri sfrecciarono via sugli sci. Mi allacciai le racchette ai polsi, accesi il walkman e partii.
Era una giornata tersa e luminosa, e il contrasto tra i riflessi del sole sul ghiaccio e l’oscurità dietro alle rocce era talmente netto che ogni tanto si aveva difficoltà a vedere persino con gli occhiali da sole. Lassù il problema non era tanto scivolare dal ghiaccio alla pietra – che almeno era visibile – ma tornare dalle rare placche di neve al ghiaccio. In entrambi i casi l’effetto era rapido e imprevedibile. Percepivo la diversa conformazione del terreno sotto gli sci: lo strepitio scricchiolante della superficie compatta e il sibilo pneumatico della fanghiglia mentre viravo in picchiata, basandomi più sulle sensazioni che sulla vista. Oltre al suono dei miei sci udivo il canto degli uccelli, non uno soltanto, ma centinaia, migliaia, un grande coro primaverile che cantava alla vita nell’avvicendarsi delle stagioni alpine. Non avevo il casco, e con il calore del sole sulla testa avevo cominciato a prendere un bel ritmo spedito, quando colpii una lastra di ghiaccio invisibile, rinculai sugli sci, mi avvitai perdendo il controllo e sbattei la testa contro una roccia.
Devo essere svenuta per qualche istante. Poi ripresi conoscenza, stesa accanto alla roccia e, abbandonati chissà dove sci e racchette, mi alzai a sedere e mi passai una mano sulla fronte. Faceva male, e c’era un bel po’ di sangue. Quando mi sollevai in piedi e brancolai alla ricerca delle racchette, dietro di me apparvero due sciatori. Guardarono prima me, poi la roccia, quindi il sangue sul ghiaccio. Uno di loro mi aiutò a recuperare la mia roba e l’altro disse qualche parola concitata in tedesco, ripetendo più volte la stessa espressione; infine mi lanciarono un’altra occhiata e ripresero a sfrecciare giù per la montagna. Mi avvolsi la sciarpa stretta intorno alla fronte, riagganciai gli scarponi agli sci e mi avviai molto lentamente nella loro direzione.
Non devo averci messo molto ad arrivare alla fine della pista, eppure ebbi l’impressione che in quel lasso di tempo fossero accadute molte cose. Non era tanto che avevo difficoltà con il ghiaccio, piuttosto qualcosa sembrava aver modificato la mia percezione dello spazio-tempo e delle tre dimensioni. Negli anni sessanta c’era gente che si dilettava a farsi buchi in fronte per cercare di raggiungere stati alterati di coscienza. Questa pratica, nota come trapanazione, si basava sull’idea che se si apriva un canale diretto verso il lobo frontale del cervello – la parte che allora si pensava filtrasse la coscienza – cadeva ogni filtro, consentendo un accesso privilegiato alla settima dimensione. Schiantandomi contro una roccia, senza volerlo avevo appena raggiunto uno stato simile. Così, durante quella discesa, feci esperienza di due versioni completamente separate della realtà altrettanto coerenti e convincenti. In una procedevo adagio sul ghiaccio, resa semicieca dal sangue che colava, con lo sguardo fisso sui pochi centimetri di terreno davanti a me. Nell’altra invece ero a casa che litigavo ferocemente con un’amica per qualche ricetta. Quella lite non era un sogno o un’allucinazione: era reale, reale come le montagne. Per qualche strana forma di atavismo una parte di me sapeva che era cruciale rimanere aggrappata solo a una di quelle due realtà, anche se non era facile capire quale.
Non so quanto tempo passò prima che nella contesa tra il ghiaccio e l’amica vincesse il primo, ma a un certo punto arrivai in fondo alla pista, alla cabina di legno accanto allo skilift. Quando apparsi sulla porta, tre soccorritori della scuola di sci erano intenti a sistemarsi gli occhiali e a completare gli ultimi controlli della slitta di soccorso.
«Je pense que j’ai besoin d’aide», dissi. «J’ai mal de tête».
Una delle guide mi guardò con gentilezza. «Allez», disse, facendomi strada nel rifugio. «Asseyez-vous.» Mi sedetti e srotolai la sciarpa. Lui mi guardò e sorrise. «Credo che non si tratti di un semplice mal di testa», disse in inglese.
«Sto bene», dissi, e scoppiai a piangere.Ai piedi della montagna il medico locale mi sottopose a una radiografia e poi mi applicò qualche punto preciso ma urticante dalla cima della fronte all’attaccatura dei capelli.
«Torni a casa», mi disse. «Sul serio, lasci perdere gli sci. Torni a casa.»
Quando ci rincontrammo all’appartamento gli altri fecero di tutto per convincermi a seguire quel consiglio, ma io non avevo nessuna intenzione di tornare a casa. Avevo vent’anni, per cui mi consideravo immortale, e per quanto mi riguardava un trauma cranico poteva risolversi facilmente con un po’ di Nurofen e qualche intruglio alcolico. Mi sembra che mi fu concesso di passare dal pavimento al divano, ma quando i miei amici capirono che ero decisa a restare, riprendemmo tutti a comportarci come se niente fosse.
Alla fine della settimana tornammo a Londra in autobus. Avevo trovato un berretto che mi copriva le ferite peggiori sulla fronte ma mi si era gonfiato il viso e la zona intorno alle palpebre cominciava a illividirsi. Non mi era venuto in mente di accennare dell’incidente ai miei, così, quando mio padre aprì la porta, si ritrovò di fronte uno strano mostro a chiazze variopinte che sembrava uscito da un film di serie b.
«Però, interessante», disse quando si riebbe dallo shock. «Quasi cubista.»
«Ti dona», disse la mia sorellina, sbarrando gli occhi. «Resterai viola per sempre?»
Sette anni dopo, quando la cicatrice sulla fronte era sbiadita fino a diventare una linea bianca quasi impercettibile, io e il ghiaccio ci incontrammo di nuovo. Uscendo da Edimburgo in una gelida notte di marzo, la mia auto prese in pieno una lastra di vetroghiaccio, slittò, si schiantò contro una siepe dall’altra parte della strada e si ribaltò.
Mi ritrovai a testa in giù, tra me e la strada solo una sottile striscia di metallo. Nell’impatto il finestrino del conducente si era frantumato, e sentivo il gocciolio del diesel sull’asfalto. Sgusciai fuori dal finestrino e restai per un po’ in piedi sul ciglio della strada, tremando per lo shock. Si fermò un camion merci che andava nella direzione opposta e il camionista chiamò i soccorsi.
Qualche tempo prima avevo visto il film Cuore selvaggio di David Lynch, in cui i due protagonisti si imbattono in un incidente automobilistico nel deserto del Nevada. Una delle vittime sembra star bene, si mette in piedi e cerca la sua borsa, ma poco dopo muore tra le braccia di Nicolas Cage. Dopo l’incidente, ritrovandomi sul ciglio della strada a notte fonda, ripensai a quel film. Forse da fuori sembravo a posto, ma se invece, come la ragazza del film, di lì a poco avessi perso i sensi nella cabina dell’autotrasportatore? Non volevo che ciò accadesse, così finché non arrivò l’ambulanza mi accoccolai sotto gli alberi e continuai a ripetere il mio nome e il mio indirizzo per non perdere qualcosa di importante – la memoria, la mia identità – sul ciglio della A702.
Poco dopo l’incidente iniziai a diventare sorda. Di colpo la mia vita si ridusse a una serie di cliché: alzavo il volume della tivù o dello stereo, chiedevo alla gente di ripetere quello che aveva appena detto, non sentivo né telefono o né il mio ragazzo Euan che infilava la chiave nella toppa per entrare in casa. Dovevo essere vicinissima al fornello per sentire il sibilo del gas a fiamma spenta. Euan si lamentava perché non ridevo più alle sue battute o, quando andava bene, ridevo a scoppio ritardato.
Mi piacerebbe dire che fu lo scemare delle voci dei bambini o lo svanire della risata di Euan a costringermi ad agire, ma onestamente non andò così: fu la paura di fare male il mio lavoro. All’epoca ero una giornalista freelance e avevo appena cominciato a scrivere il mio primo libro, incentrato sugli Stevenson, la famiglia di ingegneri a cui si deve la costruzione di tutti i fari della Scozia, che vanta tra i suoi discendenti Robert Louis Stevenson. Passai gran parte del tempo negli archivi a scartabellare tra i documenti della famiglia, ma le mie ricerche mi condussero anche negli angoli più remoti della Scozia per intervistare l’ultima generazione di guardiani dei fari.
I guardiani, come presto scoprii, si dividono in due categorie ben distinte: muti e logorroici. Con alcuni non dovevo fare altro che accendere il registratore e lasciarli parlare a ruota libera, con altri mi occorrevano ore solo per cavargli una sola parola di bocca. Ma quando poi trascrissi le interviste, notai che spesso avevo sentito male qualcosa o avevo interrotto i miei interlocutori al momento sbagliato. Va detto che certe interviste le avevo condotte all’aperto e i fari, per natura, sono alti e ventosi. In ogni caso, c’erano molti buchi nei nostri dialoghi. La grazia della conversazione era svanita, e non restava altro che una serie di osservazioni sconnesse. Sentivo tutto il mio sforzo, ma anche tutto lo sforzo dei guardiani, la punta di perplessità nella loro voce quando non riuscivo a cogliere qualcosa che avevano detto o quando me ne uscivo con un commento totalmente fuori luogo. Furono tutti molto cortesi, ma quella cortesia celava una distanza, un varco che si apriva sempre di più malgrado i miei sforzi per superarlo.
Era frustrante, lì seduta alla scrivania, alzare il volume e ritrovarmi di fronte ai miei errori. Ogni volta che ascoltavo una registrazione – facendola ripartire al massimo del volume – mi accorgevo di tutte le volte che non ero riuscita a sentire.